
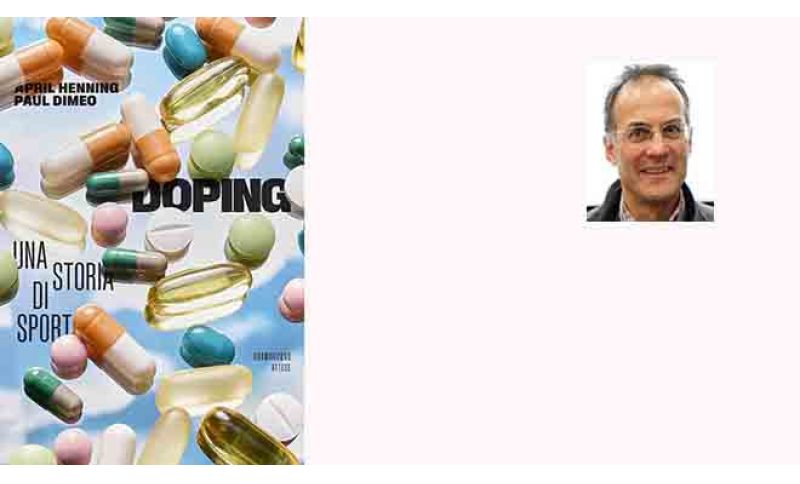
Regolarmente, nella sua natura irregolare, si torna a parlare di doping. Ematico e genetico. Meccanico e amministrativo. Individuale e di squadra se non addirittura di stato. Scientifico e tecnologico. Studiato e inconsapevole. Microdosi e maxitangenti. Le nuove frontiere, un passo sempre avanti ai controlli, chi cade dalle nuvole, chi sapeva sempre tutto ma dopo, chi sostiene che da tempo la purezza nello sport non esiste, chi aggiunge che non è mai esistita, chi denuncia i diversi pesi e le diverse misure, chi accusa di coperture e complicità, chi sospetta e spiega, anche chi si arrende, il doping sarà sempre un passo davanti al doping.
April Henning e Paul Dimeo sono gli autori di “Doping – una storia di sport” (66thand2nd, 228 pagine, 18 euro), il più recente testo sulla materia. Docenti in Scozia, Henning nella Edimburgh Business School e Dimeo nella University of Sterling, cominciano la loro analisi dalle origini dello sport moderno (ma il doping, il ricorso a intrugli innaturali elevati a soprannaturali, esisteva anche nell’antichità), un primo divieto all’uso dei farmaci già alle Olimpiadi del 1908, inutile se i controlli antidoping sarebbero stati applicati solo dopo la morte di Tom Simpson, Mont Ventoux, Tour de France 1967.
La stricnina offerta ai maratoneti ai Giochi del 1904 e 1908, le amfetamine a calciatori e ciclisti negli anni Cinquanta, gli steroidi generalizzati negli anni Sessanta e Settanta, l’eritropoietina negli anni Novanta e Duemila fino allo scandalo di Lance Armstrong, non c’è disciplina, specialità, ambito libero dal doping. Nonostante i rischi, i pericoli, i test, le condanne. Un inquinamento non solo a livello agonistico, ma anche in quello amatoriale.
Henning e Dimeo sono documentatissimi. I casi più celebri, da Ben Johnson al caso Festina attraverso la cocaina di Diego Maradona e le fughe di Costas Kenteris e Katerina Thanou, una serie infinita di trasgressioni e bugie, punizioni e condoni, ricoveri e arresti, vicende che a volte possono anche sembrare sospette o ridicole, se non addirittura combinate o svelate solo come prova – una tantum – dell’efficacia di un sistema comunque inefficace o impotente. Tanto che i sospetti – nei muscoli, nelle prestazioni, nei pettegolezzi - restano. E la documentazione, dal punto di vista britannico, amplia quella genericamente italiana.
Che fare? “Il futuro dell’antidoping – scrivono gli autori – può essere diverso, più democratico, umano e rispettoso, ma solo se gli atleti verranno coinvolti e ascoltati”. Henning e Dimeo sostengono che non esiste un’adeguata preparazione, educazione, conoscenza da parte degli stessi atleti, così come esiste la superficialità di medici e massaggiatori, così come esistono falle e discrepanze all’interno delle agenzie antidoping, così come esistono coperture e complicità di federazioni. C’è forse troppa accondiscendenza verso gli atleti, qui ritenuti quasi sempre vittime e non artefici. Come nel caso di un balsamo per labbra della fondista norvegese Therese Johaug o di un prodotto contro la calvizie dello specialista di skeleton statunitense Zach Lund. E c’è forse anche troppa prudenza verso la quantità: “Si cerca la semplice presenza piuttosto che il superamento di un livello di soglia”. Come nel caso del clenbuterolo di Alberto Contador.
Il quadro è desolante. La questione doping è economica e morale. Se il valore più importante è l’ingaggio strappato e non la parola data, non c’è antidoping che tenga. E se non ci sono valori etici, culturali, familiari, il doping avrà sempre via libera.
